Ho in casa, anzi a dirla tutta in auto, da almeno un paio di mesi l’ultimo disco di Giancarlo Frigieri. Ascoltai Sant’Elena per intero quasi con avidità già nei primi giorni dopo che Giancarlo me lo aveva fatto trovare al Galaxy Beer Shop di Rubiera, poi però non me la sentii più di approfondire l’ascolto. Il primo fu così impattante e a tratti doloroso, dal farmi desistere dall’infliggermi una scarnificazione in un momento proprio per nulla di forza. Della forza necessaria ad affrontare con serenità ed il dovuto coraggio, l’introspezione a cui i circa 70 minuti di questo album mi avrebbero forzato.
La brutale semplicità del voce, chitarra, solo sporadicamente accompagnate da una discreta armonica, possono catapultare o nella noia o nel buco nero di sé stessi. Chi mi conosce bene mi aveva anche avvertito prima che le cose potevano andare così e che purtroppo per me, il disco non mi avrebbe per nulla annoiato. Fatto sta che oggi mentre tornavo da Febbio verso Piastrella Valley, con un colpo di coraggio e forse perché so che è inutile sfuggire agli specchi, ho deciso di tuffarmi di nuovo nel rischio di farmi del male riascoltando Sant’Elena.
Io non saprei giudicare il talento di Giancarlo nel suonare la chitarra dal punto di vista tecnico, posso solo dire che lo fa in un modo che mi piace, anzi sarebbe più corretto dire che mi allieta e che vederlo scancherare su quello strumento per me così impossibile, mi ha sempre affascinato. Da profano ho sempre pensato che “vacca d’un cane s’è togo!”. Qui però il problema, o meglio il bello, non sono (solo) le melodie e gli arpeggi, ma la totale mancanza di fronzoli e in un certo qual senso quella sincerità che nel nostro mondo viene ormai bollata come eccessiva e quindi fouri luogo. Quella che io non so fare a meno di amare e desiderare, ma che sempre meno vedo presente intorno a me. Una brutalità, come dicevo prima, che risucchia fin dalle prima note in un vortice emozionale dentro il quale a prevalere è l’amarezza.
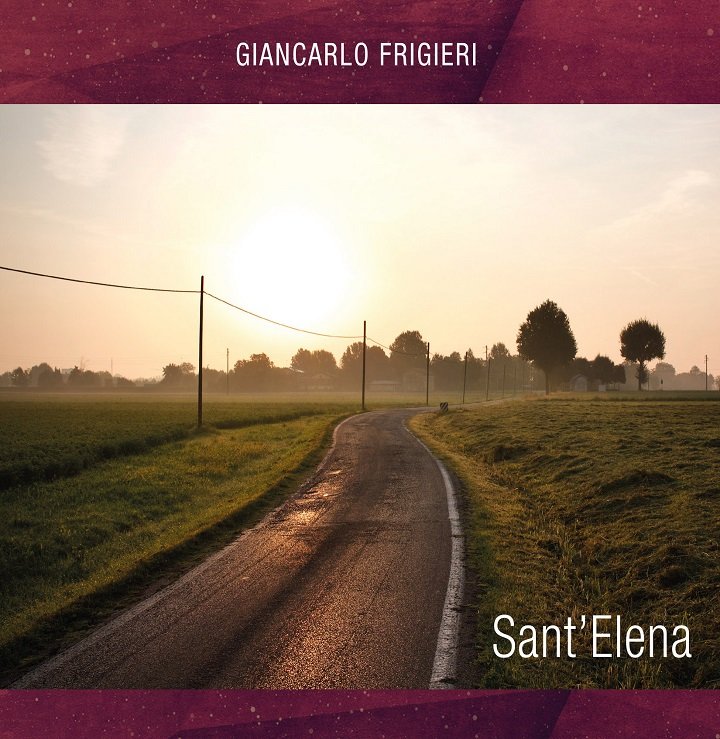
L’amarezza che pare uscire da una retorica così retrò e corposamente sostanziale, da lasciare con il mal di pancia. La disillusione che sembra uscire dalla vita di chi ascolta, quei pezzi di passato e di nostalgia che così tanto e da tanto macinano dentro lo stomaco, senza essere ancora stati digeriti. Che probabilmente non lo saranno mai e che qui ti vengono sbattuti in faccia senza alcuntipo di filtro, ma di certo non con cattiveria: come in natura non c’è dolo negli aspetti più brutali, ma solo ineluttabilità del come funzionano le cose. Come dicevo poco sopra semplicemente con sicerità, o meglio con onestà. Inopportuna? A mio modo di vedere no. Perché l’onestà non può esserlo, se non in un mondo che preferisce crogiolarsi nelle menzogne, per paura della solitudine e l’incapacità di farvi fronte.
Storie di tutti i giorni, di fallimenti, delusioni, annichilimento personale e appunto amarezze profonde. Storie che sono così dure da riconoscere come parte integrante delle nostre esistenze, dal rendere il disco proprio uno specchio capace di mostrare le verità che con così tanta fatica avevamo trovato il modo di nascondere.
Ovviamente non manca l’ironia che spesso si vela di sarcasmo. Fantasia, tanta, ma di veramente inventato, probabilmente, nulla.
Beh, insomma, questo l’effetto che ha fatto a me…e che mi ha anche ispirato a scrivere alcuni versi in dialetto, che se v’interessano trovate qui.

Lascia un commento